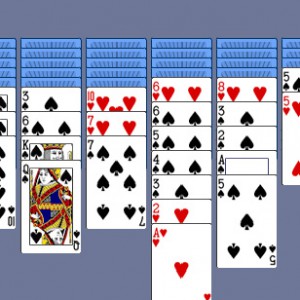Ho letto tanto in questi giorni riguardo alla questione della foto del piccolo bimbo siriano, riguardo all’opportunità o meno di pubblicare la foto, cruda, del bambino siriano adagiato sulle coste della Turchia e coccolato, per l’ultima volta, dalle onde calme di quel mare che ha interrotto bruscamente il viaggio verso le coste europee e sopratutto la sua piccola vita.
Ho letto tanto in questi giorni riguardo alla questione della foto del piccolo bimbo siriano, riguardo all’opportunità o meno di pubblicare la foto, cruda, del bambino siriano adagiato sulle coste della Turchia e coccolato, per l’ultima volta, dalle onde calme di quel mare che ha interrotto bruscamente il viaggio verso le coste europee e sopratutto la sua piccola vita.
Ho letto perché, prima di provare nel mio piccolo a dire qualcosa, mi piace provare ad ascoltare e capire.
Le scuole di pensiero sono molto diverse: c’è chi ha deciso di pubblicarla per mettere in evidenza la crudeltà e l’incancellabile evidenza, che tante volte fingiamo di non vedere e con cui non vogliamo fare i conti; c’è chi invece ha deciso di censurare e se l’è un po’ presa con i primi, sostenendo che pubblicare questa foto serva soltanto per pulirsi per un attimo la coscienza, ad un attivismo da tastiera, tra un selfie delle proprie vacanze e l’altro.
Credo, e provo a dirlo con gli occhi di chi sta studiando comunicazione, che siano e debbano essere ritenute entrambe scelte rispettabili. Credo, cioè, che dovremmo pian piano incominciare a recuperare la capacità di accettare l’idea di essere esseri complessi e come tali riuscire quindi a tenere intelletualmente insieme cose e convinzioni che paiono diametralmente diverse come può essere il codice deontologico del giornalista o del comunicatore con la scelta di mettere in prima pagina quella che, penso nessuno lo possa negare, sia diventata un’icona che riassuma un dramma. Ognuno di noi ricorderà la fotografia della bambina vietnamita con le braccia alzate. Ecco, come quella anche questa diventerà un’immagine emblematica da libro di storia. Perché è questo che a mio modo di vedere rappresenta quella foto: un’icona di una questione tremendamente molto più complessa e complicata che è improvvisamente scoppiata nelle mani dei governi europei, che pure non potevano non aver colto le avvisaglie dei decenni di viaggi della speranza attraverso il Mediterraneo.
La scuola di pensiero della censura ritiene che non bisogna speculare sul dolore e sulle vittime, a maggior ragione se bambini. E’ vero, un’immagine del genere passa nelle nostre timeline su Facebook o davanti agli occhi al bar mentre leggiamo il giornale in mezzo ad un bombardamento di tante altre cose oltremodo futili e rischia di diventare routine, banalizzata. E’ vero, condividere su Facebook o retweetare una foto su Twitter è un’azione assolutamente comoda, rapida ed indolore, per certi versi, per pulire la propria coscienza.
Ma, c’è un ma. Sappiamo e conosciamo questa enorme tragedia, ma viviamo in una società dove, immersi in un bombardamento informativo senza precedenti sono le immagini che attirano l’attenzione. Tanto vero che in tutti i corsi di Social Media Marketing che ho frequentato la parola d’ordine è: puntare sull’aspetto visuale delle immagini. Perché è l’immagine che interrompe il flusso ininterrotto di parole. Non è infatti vero che oggi tutto quello che non è selfato, fotografato e sopratutto mostrato ed ostentato, semplicemente non c’è? E se poi la fotografia mostra la morte, per di più di un bambino, è il nostro innato spirito di conservazione e protezione che viene toccato. E allora, forse, “vediamo” e non riusciamo ancora una volta a voltarci di fronte a questo dramma, e comprendere, attraverso la storia di Aylan tutte le altre che abbiamo fino ad ora ignorato e che la sua racchiude drammaticamente. Sono convinta di ciò: abbiamo bisogno di vedere per tornare a contatto con la cruda realtà, anche per quel misero secondo in cui l’immagine ci scorre davanti agli occhi. Pena il rischio di anestetizzare il nostro cuore e la nostra mente davanti a ciò che succede per davvero, attorno a noi.
Io personalmente ho deciso che non avrei condiviso questa foto sul mio profilo Facebook, l’avevano già fatto praticamente tutti e mi sembrava non avrebbe aggiunto nulla. Ma il mio cuore non può fare a meno di sussultare ogni volta che appare nella mia timeline, in questi ultimi giorni anche in versioni più poetiche ed ancora più evocative. E’ una fitta che mi fa male, un male tremendo perché mi sento impotente.
C’è una frase di una canzone di Jovanotti che in questo periodo mi risuona spesso in testa, leggendo queste polemiche: “Ma l’unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente“. Andatevela a risentire, questa canzone. Il pericolo dell’indifferenza, delle immagini che mi passano davanti senza suscitarmi più indignazione, rabbia, dolore, sgomento, angoscia. Quest’estate, accarezzando il mare in cui io cercavo riposo e che per altri è invece l’unica agognata via di fuga, c’era una domanda che, senza risposta, in modo martellante si faceva spazio dentro alla mia testa: “Per quale merito, io sono nata da questa parte del mare? Per quale coincidenza il mare per me è sintomo di spenseriatezza e per altri rappresenta la tomba azzurra?”.
Tornando alla querelle pubblicare la foto sì, pubblicare la foto no, quello che mi sembra emerga in entrambe le parti sia il non renderci conto, ancora una volta, che mettendo la nostra attenzione su questo aspetto continuamo ad ergerci noi al centro dell’attenzione e del discorso. Noi che giudichiamo, chi ha fatto bene e chi ha fatto male. Ognuno ha la sua sensibilità, il suo modo di sentire le cose. Io, ad esempio, pur non essendo in questo caso contro la pubblicazione di queste foto, lo sono stata nei confronti del video del giornalista americano che ha ucciso due colleghi e lo sono per le immagini delle uccisioni dell’ISIS. Perché per me, quelle immagini che mostrano come uomini e donne muoiono, portano in campo aspetti semantici, se così posso dire, diversi.
Noi siamo qui che ci accusiamo a vicenda di aver pubblicato o non aver pubblicato e ci guardiamo il dito; ed intanto dalla Libia, dalla Siria o chissà ancora da dove un altro barcone, con tanti Aylan sopra, è già partito.
Certo, il rischio di anestitizzarci davanti al dolore, alla sofferenza, all’ingiustizia è qui, ben presente. Ma il problema io non credo che sia una foto che passa veloce nella nostra timeline di Facebook. Il problema è che stiamo mettendo l’accento su una foto e l’opportunità di pubblicarla o meno trascurando colpevolmente di parlare di ciò che quella foto rappresenta e del dramma di cui quella foto diventerà tristemente un simbolo, come tante prima di lei nella storia.
Vorrei e spero che questa foto diventasse piuttosto il motivo per discutere e per interrogarci nel profondo di quello che riguarda le questioni dei flussi dell’immigrazione e di ciò che ne è, ancor prima, causa. Che diventasse, come potrebbe dirci un semiotico, il significante che ci riporta ad un significato molto più profondo.
Aylan non è morto invano se qualcuno si mette una mano sulla coscienza, se prendiamo consapevolezza del terribile ruolo che l’Europa (o, a seconda, non) ha nelle guerre che falcidiano l’area araba e non solo. Non sarà morto invano fino, dopo aver adeguatamente pensato ora ad accogliere e farsi carico di chi da quelle terre scappa, non si troverà una soluzione, anche alla radice del problema.
La foto di Aylan appartiene alla storia. La sua, personale, del sogno della sua famiglia di andare in Canada, ma anche quella di ognuno di noi.
Per me questa foto rappresenta però anche uno specchio davanti a cui vedere la mia indifferenza quotidiana verso il mio prossimo. Quello che mi passa accanto ogni giorno. Ecco, Aylan non sarà morto invano ogni volta che la sua foto sarà per me il deterrente alle mie, piccole, guerre personali, quelle di tutti i giorni.
Io non posso fermare le guerre, non ho facoltà di decisione sulla sorte di chi attraversa il mare in cerca di una nuova, flebile speranza di vita. E’ colpa degli Stati Uniti, di chi vende le armi. Non penso sia un grande scoop. Ma poi io, concretamente, in tutto ciò che ruolo attivo posso davvero avere? Posso forse andare da Obama e dirgli: “senti un po’, basta vendere armi, ok?”. Forse no.
Forse vederci sbattuta davanti la foto di Aylan ci disturba non solo per l’ingiustizia, l’orrore e il dolore che ci racconta. Ma perché inconsciamente, a noi che dobbiamo sopportare la frustrazione di non avere il necessario potere di influenzare chi prende le decisioni politiche, quella foto chiede di cambiare e di prendere decisamente la strada della fraternità quotidiana, l’unica che possiamo percorrere concretamente per provare a cambiare davvero qualcosa. E quella foto sta lì, implacabile, a ricordarcelo. A ricordarci che non possiamo lasciare ad altri il compito di costruire un mondo un po’ migliore. E allora, riguardiamocela ogni giorno, questa foto. Perché a dimenticare si fa molto in fretta.
La foto di Aylan forse qualcuno ha smosso, più di quanto abbiano fatto tante parole pronunciate negli ultimi tempi. Ma in quella foto c’è Aylan, c’è una storia, c’è un popolo. Ed è a lui, al suo fratello e alla sua mamma, a suo padre rimasto in vita, a quanti sono morti con lui nella traversata e di cui non abbiamo una fotografia, a chi chiede una mano per avere una vita diversa e migliore che dobbiamo che il dolore e lo sgomento che il suo viso adagiato per sempre sulla battigia di una spiaggia diventi una molla: per non girarci più dall’altra parte ed essere, invece, parte del cambiamento di questa storia.
Non siamo solo italiani, francesi, tedeschi, siriani…siamo tutti cittadini di questo stesso mondo e abbiamo tutti lo stesso desiderio di felicità: è arrivato il momento di smettere di chiederci se sia giusto o sbagliato salvare e aiutare questa gente, ma di discutere solo di come farlo, e se potranno esserci dei rischi anche per noi beh…credo valga la pena correrli. [1].
“Perché l’unico pericolo che sento veramente, è quello di non riuscire più a sentire niente”.
 Stamattina sul pullman mi è caduto distrattamente l’occhio su una ragazza che seduta vicino all’obliteratrice, la mia meta di quel momento, armeggiava con un modellino di plastica. Un passatempo davvero insolito, considerando che la posa comune ormai è quella di due occhi chinati sul proprio smartphone – e io non faccio differenza, in questo, approfittando di questi tempi vuoti per leggere un po’ di cose utili per il mio aggiornamento professionale day-by-day.
Stamattina sul pullman mi è caduto distrattamente l’occhio su una ragazza che seduta vicino all’obliteratrice, la mia meta di quel momento, armeggiava con un modellino di plastica. Un passatempo davvero insolito, considerando che la posa comune ormai è quella di due occhi chinati sul proprio smartphone – e io non faccio differenza, in questo, approfittando di questi tempi vuoti per leggere un po’ di cose utili per il mio aggiornamento professionale day-by-day.


 Ho letto tanto in questi giorni riguardo alla questione della foto del piccolo bimbo siriano, riguardo all’opportunità o meno di pubblicare la foto, cruda, del bambino siriano adagiato sulle coste della Turchia e coccolato, per l’ultima volta, dalle onde calme di quel mare che ha interrotto bruscamente il viaggio verso le coste europee e sopratutto la sua piccola vita.
Ho letto tanto in questi giorni riguardo alla questione della foto del piccolo bimbo siriano, riguardo all’opportunità o meno di pubblicare la foto, cruda, del bambino siriano adagiato sulle coste della Turchia e coccolato, per l’ultima volta, dalle onde calme di quel mare che ha interrotto bruscamente il viaggio verso le coste europee e sopratutto la sua piccola vita.